
Gallura
Un viaggio dai sapori antichi
Dici Gallura e pensi subito mare, granito, sughero e vento. Che poi fanno tutto un insieme: non solo paesaggio, ma anche modo di essere un popolo, una civiltà. Mare, da queste parti, vuol dire Costa Smeralda, arcipelago della Maddalena, Bocche di Bonifacio, Costa Paradiso: alcuni dei luoghi che molti considerano tra i più belli al mondo. La Gallura ha colori incredibili, che valgono da soli l’intera vacanza. Il merito è anche del granito, che regala all’acqua trasparenze spettacolari, come spettacolari sono le rocce, giganteschi capolavori naturali e autentiche protagoniste del paesaggio. La quercia da sughero è un’altra figura essenziale di questa terra: non solo per l’apporto che dà all’economia di intere popolazioni (Calangianus è giustamente considerata la capitale italiana della lavorazione del sughero), quanto per il particolare aspetto che conferisce al paesaggio quella loro inclinazione a sud-est, dovuta alla forte e persistente azione del maestrale. Vento che qua la fa da padrone, compagno abituale dei sardi e amico delle migliaia di velisti e surfisti che popolano d’estate le acque galluresi.
Senza capire questo paesaggio non si capisce la Gallura. Che non è solo mare. La Gallura è anche il suo interno, tutto verde e vallonato, con strade che fanno buffi saliscendi lungo i pendii. Lo punteggiano le case bianche che si chiamano “stazzi” (dal latino statio, luogo dove ci si ferma), cuore dell’azienda familiare che vive del lavoro dei campi, di allevamento del bestiame, del bosco per la legna, della vigna per l’aspro vino, dell’orto per le provviste di casa. È da qui, dagli stazzi, dalla vita morigerata e severa dei suoi contadini-pastori, che viene quella che chiamano la “civiltà gallurese”. E siccome è anche civiltà del mangiare, trae ancora oggi dalla tradizione dello stazzo la sua cucina più tipica.
La cucina tipica
Sontuoso piatto d’obbligo è la suppa, una zuppa che dicono anche cuata, cioè “nascosta”, pare perché sormontata da una crosta brillante di formaggio. La suppa è il piatto forte del pranzo nuziale: e infatti la chiamano anche suppa di còju, di nozze. La cucina di mare è scoperta più recente. Certo esisteva da prima, portata soprattutto dalle numerose, attive colonie di pescatori (quasi sempre ponzesi) che venivano a stabilirsi su queste coste. Il turismo, promovendo quei borghi solitari a piccoli paradisi estivi, ha esaltato le pietanze povere di chi viveva tra reti, palamiti e barche. Lo zimino, per esempio, è la zuppa di pesce, che aveva per ingredienti tutti i pesci che non potevano andare sul mercato, ma ottimi per il sugo. La galletta faceva il resto. Questa popolazione abituata(meglio dire, costretta) a sfruttare ogni angolo del mare si è trovata anche due delikatessen che hanno un mare di affezionati: le cozze (il golfo di Olbia ne ospita allevamenti che sono tra i più grandi d’Italia) e i ricci. I ricci sono un frutto di primavera, ma si possono mangiare tutto l’anno. Non temono gli inquinamenti, e la Gallura ha centinaia di spiagge mai toccate dal piede umano. Un tempo c’erano anche le gnàccare, nome locale di quella che gli scienziati chiamano pinna nobilis: enormi molluschi bivalvi, simili a grandi pale di fichi d’India, confitti verticalmente sul fondo del mare più quieto. Chi faceva il bagno al Cannigione, sino a una trentina d’anni fa, vedeva questa foresta rameggiare immobile dieci metri più in basso. Del muscolo si faceva una splendida insalata, il ventrame si friggeva fino a farne un pasticcio piccante, si diceva anche amabilmente afrodisiaco.
Regina del menu di mare è Sua Maestà l’Aragosta. Se n’è pescata tanta, in questi ultimi anni, che la Regione ha dovuto ordinare un periodo annuale di fermo biologico. Un tempo la sua pesca era centrale nella modesta economia dei villaggi di pescatori: velieri venivano a caricarla un po’ dappertutto per portarla a Genova o, meglio ancora, a Marsiglia. La stiva era forata in modo da farci passare acqua di mare sempre fresca: altrimenti l’aragosta, che è animale delicato, avrebbe sofferto e alterato il proprio sapore. Allo stesso modo, una volta pescata, in attesa che arrivasse il veliero, veniva collocata dentro cassoni di legno, immersi a pelo d’acqua, in modo da restare in mare. Quando le aragoste si urtavano, le antenne più sottili si rompevano, provocando l’inquinamento della gabbia e la morte delle aragoste. Per questo i pescatori visitavano i vivai due volte al giorno, e toglievano quelle ferite o danneggiate. L’operazione, essenziale alla sopravvivenza del pescato, attivava un curioso mercato, detto sbrigativamente “delle aragoste morte” (leggi piuttosto moribonde). Le si vendeva a prezzo di saldo, sicché prima dell’invasione turistica (che si data per comodità al 1962, anno di fondazione del Consorzio della Costa Smeralda) si poteva mangiare l’aragosta a prezzi più bassi del pesce “normale”.
I dolci tipici di Gaddhra
I galluresi, di bocca dolce, usavano il miele spesso nella loro cucina. In particolare nelle decine di varietà di dolci (prime fra tutti li cucciuleddhi e meli, canestrini di pasta, pasta di mandorle e miele, e le origliette, piccoli rombi di pasta fritta: “piccoli cuscini”, dallo spagnolo) e soprattutto nelle frittelle, li frisgioli longhi, frittelle lunghe a volte anche un metro, che i galluresi doc non mangiano se non sepolte di zucchero e miele. Sono un dolce tipico del periodo di Carnevale, ma la cucina turistica le ha allungate fino all’estate. In verità, il dolce principe del menu estivo è la sebada o seada (al plurale si aggiunge una esse e fa sebadas, seadas: state attenti a non dire “una sebadas”, anche se ormai quest’uso è invalso anche nei camerieri indigeni). Il nome viene da seu, lo strutto con cui si prepara la pasta che serve a fare una focaccina ripiena di formaggio fresco, possibilmente acidulo, fritta e naturalmente mielata e zuccherata. Anche lo stazzo gallurese conosceva un dolce di questo tipo (si chiamava la siata), ma è il turismo che l’ha fatta atterrare sui tavoli galluresi dai pascoli della Sardegna interna.
Il vino e i frutti della terra
Finiamo con la frutta. La Gallura produceva un tempo (a Santa Teresa di Gallura, per esempio) angurie e pesche da concorso. Ora è fortuna se arrivano dai vicini campi del Coghinas o dai frutteti di Arborea, nell’Oristanese. A voler restare sul locale, si potrebbe scegliere l’uva: se non altro per rendere omaggio ai famosi vini, tutti doc e qualcuno anche dogc, che si fanno tra Tempio – patria di famosi vermentini – e Arzachena, dove un’azienda privata fa ottimi rossi per la carne e inarrivabili bianchi, tra cui il mitico Capichera, per il pesce.
Ma un frutto che, come si dice oggi, intriga molto il visitatore è il fico d’India. Un frutto di piena estate, stagione di climi densi. Cresce a siepe sui muretti delle tanche, un trionfo di gialli e di rossi. Ed è gratis. I galluresi dicono scherzando che al turista piacerebbe molto di più se qualcuno gli dicesse che, prima di mangiarlo, bisogna togliergli la buccia spinosa.
Dici Gallura e pensi subito mare, granito, sughero e vento. Che poi fanno tutto un insieme non solo paesaggio ma anche modo di essere un popolo, una civiltà.
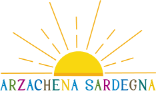

No Comments